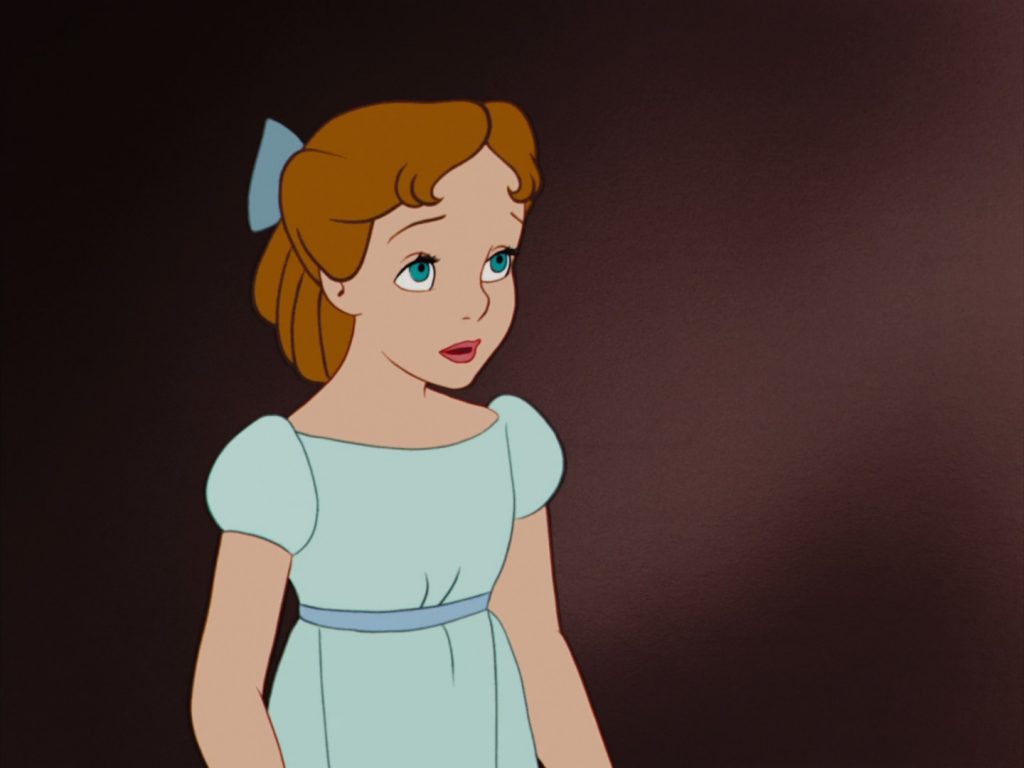Ripercorriamo la complessa storia del colore rosa, discutiamo delle sue connotazioni di genere e affrontiamo gli stereotipi associati all’iperfemminilità attraverso l’analisi del film La rivincita delle bionde (Legally Blonde, 2001).
Breve storia del colore rosa in Occidente
Che sia blu o che sia rosa?
Che sia rosa!
Flora ne La Bella Addormentata (1959)
L’eterno diverbio fra Flora e Serenella, le fate del classico Disney La Bella Addormentata (1959), riflette una diatriba interna allo studio d’animazione, nonché un dilemma che si stava facendo strada nella società dell’epoca: per una ragazza è meglio il blu o il rosa?

Chiunque abbia una passione ossessiva per il classico Disney in questione avrà notato che, nell’ultimissima scena in cui compare, l’abito è rosa.
Tuttavia, esso appare in azzurro per la gran parte del film, ed è raffigurato in questo modo in gran parte delle locandine e dei libri dell’epoca.
Quando però, all’inizio degli anni 2000, nasce e si sviluppa il franchise delle principesse Disney, l’abito diventa definitivamente rosa.
Un po’ per distinguerlo da quello di Cenerentola (che nel merchandise diventa azzurro), un po’ perché nella line-up non poteva mancare una principessa con un abito rosa.
Questo sancisce la vittoria postuma di Flora, ma anche la conferma di un nuovo schema socio-culturale: il rosa è diventato il colore simbolo della femminilità in senso tradizionale, o dell’iper-femminilità.

Questa codifica di genere caratterizza la vita di ogni donna fin dalla nascita: alle bambine il rosa, ai bambini l’azzurro.
Ma non è sempre stato così.
Partiamo da un assunto: in Occidente, il colore rosa ha una storia sociale relativamente breve, ma molto complessa.
La sua presenza in natura è limitata, tanto che il termine “pink” entra nella lingua inglese solo nel XVII secolo: per questo motivo, la pubblica concezione di questo colore passa attraverso il suo utilizzo nell’arte e nella moda.
Il suo ingresso nella moda, e nell’interior design, risale alla metà del 1700.
Gli uomini e le donne dell’aristocrazia europea cominciarono a vestirsi di rosa – e di altri colori nelle tonalità pastello – come simbolo del loro status sociale.
Bambine e bambini, tuttavia, continuavano ad essere vestiti con abiti di colore bianco, l’unico colore che non sbiadiva a seguito di numerosi lavaggi.
Alla metà del XIX secolo, le tonalità pastello divennero popolari anche per bambine e bambini, ma l’azzurro e il rosa venivano utilizzati indifferentemente dal genere di appartenenza.
La divisione “gender specific” cominciò ad essere messa in atto da alcuni negozi solo all’inizio del XX secolo, secondo una logica che vi stupirà.
Nel 1918, la rivista di settore Earnshaw’s Infants’ Department scriveva che:
La regola generalmente accettata è rosa per i bambini, azzurro per le bambine. La ragione è che il rosa, essendo un colore più deciso e forte, si addice di più al bambino, mentre il blu, che è più delicato e grazioso, sta meglio indosso alla bambina.
“The generally accepted rule is pink for the boys, and blue for the girls. The reason is that pink, being a more decided and stronger color, is more suitable for the boy, while blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the girl.”
Una situazione ribaltata rispetto a quella che tutti conosciamo: il rosa, visto come una versione pastello del rosso, sembrava rimandare alla guerra e quindi al comando, al vigore, alla passione e all’energia maschile, mentre l’azzurro veniva associato a doti stereotipicamente ritenute “femminili” come la calma, la tranquillità, la modestia, la grazia, la perseveranza, la fedeltà – non a caso, la Vergine Maria viene spesso raffigurata con abiti azzurri.
La divisione non era ancora così netta, ma la maggior parte degli adulti americani rimane fedele a questa codifica per decenni.
È probabilmente questo il motivo per cui molte eroine Disney pre-La Bella Addormentata indossano abiti nei toni dell’azzurro, soprattutto se bambine: pensiamo a Alice di Alice nel paese delle meraviglie (1951) e a Wendy di Le avventure di Peter Pan (1953), in cui la camicia da notte azzurra della bambina si contrappone al pigiama rosa del fratello minore.

Johannes Cornelisz Verspronck, Portrait of a Girl in Blue Dress, 1641.
E, se la storia porta Cenerentola a sostituire un abito rosa con uno che… beh, non è azzurro, ma comunque ci si avvicina, per Aurora la scelta sembra propendere, a conti fatti, per il rosa.
La scelta, però, per Aurora e per tutte le ragazze del mondo, non è personale, ma è dettata dall’esterno: allo stesso modo in cui la società aveva deciso che l’azzurro avrebbe potuto incarnare al meglio le doti che ci si aspettava da una giovane donna, a un certo punto inverte la rotta e decide arbitrariamente che sarà il rosa a incarnarle.
In un modo o nell’altro, si tratta di un costrutto sociale che spinge le bambine e i bambini a preferire un colore rispetto all’altro, in modo completamente arbitrario.
Ma com’è avvenuto questo cambiamento di rotta?
Edward Bower, Portrait of a young boy in pink silk […], 1634.
Immagine di uomo vestito di rosa, Pierre-Thomas LeClerc, 1779.
Master Nicholls (The Pink Boy), Thomas Gainsborough, 1782.

Rosa, lo stereotipo della femminilità
La società decide il significato dei colori.
Valerie Steele
Nel cercare la connessione fra il colore rosa e il concetto di “femminilità”, facciamo un passo indietro.
Secondo Valerie Steele, curatrice del libro e della mostra Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color (2018-2019), la più antica associazione fra le donne e il rosa trova le sue radici attorno alla metà dell’800, quando “gli uomini occidentali cominciarono a indossare abiti di colori scuri e sobri”, lasciando le tinte pastello alle donne.
Come dicevamo, per secoli i colori pastello furono associati all’infanzia. Come scrive Jo B. Paoletti in Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America, il loro utilizzo non era volto a fare distinzioni di genere, ma di età: l’azzurro e il rosa venivano indossati – in modo interscambiabile – più dalle bambine e dai bambini che dalle donne e dagli uomini. Dal momento in cui le donne adulte cominciano ad indossare abiti nelle tinte del rosa pallido, la concezione della femminilità si lega a quella dell’infanzia: il rosa diventa un simbolo di dolcezza e innocenza, ma anche di immaturità, debolezza, inferiorità.
Allo stesso tempo, il rosa comincia ad assumere connotazioni erotiche nell’arte e nella letteratura in quanto sembra rimandare all’organo sessuale femminile, tanto che diventa un colore molto popolare nella produzione di lingerie. Quando, all’inizio del ‘900, la produzione di massa diffonde tinte di rosa più audaci e sgargianti, tendenti al magenta, il processo di sessualizzazione del colore raggiunge il suo picco: il rosa passa dalla nobiltà alla classe operaia, dalle aristocratiche alle prostitute.
Il rosa incarna quindi due diverse concezioni stereotipate della femminilità: da un lato la donna virginale, pura e innocente come una bambina (e per questo anche mentalmente inferiore, dipendente, capricciosa), dall’altro la donna promiscua, la provocatrice, la “puttana”.
Insomma, si torna sempre al complesso Madonna-Whore, che presenta due sole opzioni di essere donna, entrambe soggiogate dal sistema patriarcale.
Nel 1936 nasce il rosa shocking, da sempre legato alla sensualità femminile: appare per la prima volta nella confezione del profumo Shocking de Schiaparelli, al cui interno era presente un flacone modellato sul corpo dell’attrice Mae West.
La vivacità di questo colore entra in contrasto con il clima sociale e politico degli anni ’30, quando l’Europa si preparava alla Seconda Guerra Mondiale.
La tinta troverà la sua massima consacrazione al termine del conflitto, legandosi indissolubilmente al concetto di “femminilità”.
Anche il carattere di scrittura associato al “rosa Schiaparelli” sembra essere legato a un’idea di femminilità estrema, come evidenziato dagli opening credits di film come Gentlemen Prefer Blondes e Legally Blonde.
Facciamo di nuovo un salto in avanti, siamo nel Secondo Dopoguerra.
È in questo periodo che il colore assume definitivamente la connotazione di genere che permane ancora oggi.
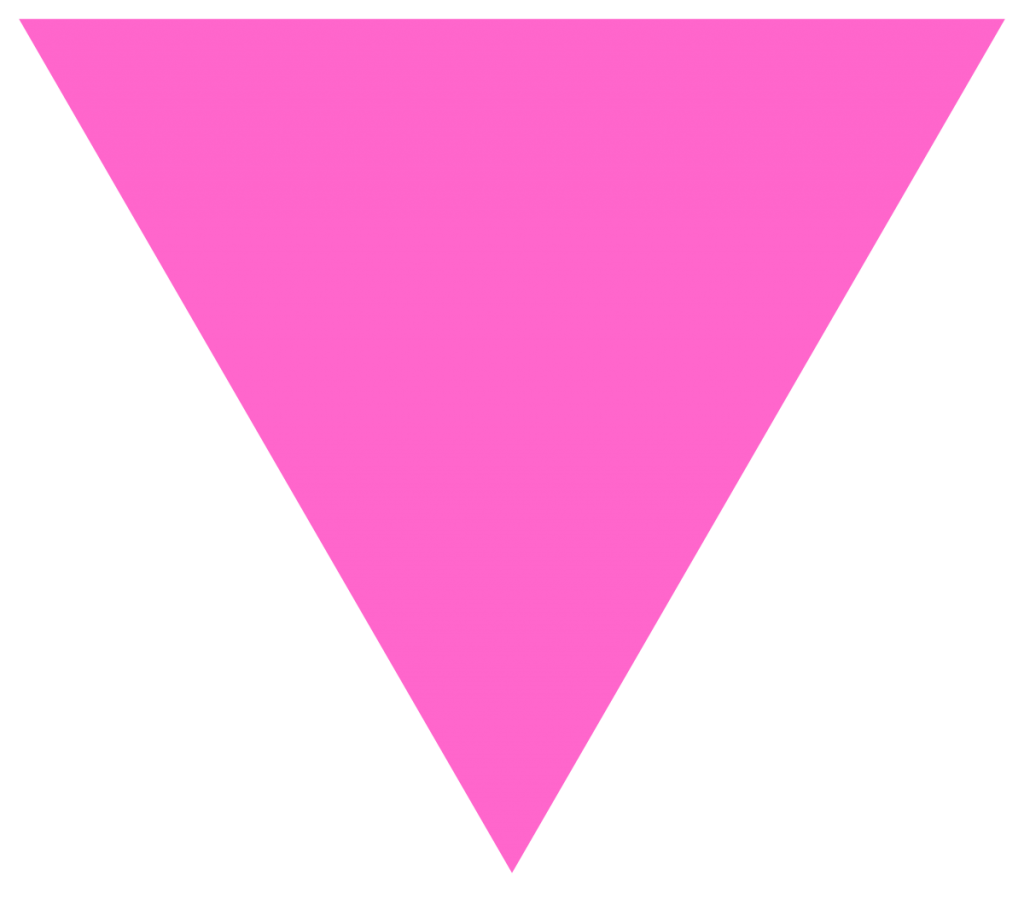
Al termine della Guerra, che aveva visto gli uomini al fronte e le donne al lavoro nelle fabbriche, la società aveva bisogno di ristabilire una forte divisione dei ruoli: gli uomini a lavoro, le donne a casa.
Nel connotare il ruolo più che mai conservatore che la donna assumerà negli anni ’50, le agenzie pubblicitarie cominciano ad effettuare una divisione cromatica che si riversa soprattutto sui prodotti femminili.
Abbandonati gli abiti modesti e i colori spenti della Guerra, le donne sono incoraggiate dalla spinta consumistica a riabbracciare la moda e, con essa, la femminilità più tradizionale, attraverso prodotti specificatamente rivolti a loro, che si tingono di rosa.
La parola d’ordine è “Think Pink!”, come nel celeberrimo numero musicale di Funny Face (Cenerentola a Parigi, 1957): così, le donne americane abbandonano la casacca blu di Rosie The Riveter per inforcare il grembiule rosa di June Cleaver.
A legare indissolubilmente il rosa alla figura della casalinga modello degli anni ’50 ci ha pensato la forte presenza mediatica della First Lady Mamie Eisenhower, che al Ballo per l’inaugurazione presidenziale del marito Ike aveva indossato un abito rosa decorato di strass: era il 1953.
Il rosa era il colore preferito della nuova First Lady e tutti i media lo ricondussero all’aria di docile e rassicurante “domesticità” che la sua immagine restituiva: “Ike governa il Paese, e io giro le costolette di maiale”, aveva dichiarato.

Nello stesso anno, il rosa diventa l’emblema della sessualità esplosiva di Marilyn Monroe nella celeberrima sequenza Diamonds Are A Girls’ Best Friends de Gli uomini preferiscono le bionde.
Il colore rispecchia quindi, più che mai, la dicotomia “santa-puttana”, legandosi indissolubilmente agli estremi opposti della femminilità, e a tutti gli stereotipi ad essi connessi.

Alla luce di quanto detto, appare evidente come il femminismo abbia vissuto un rapporto conflittuale con il rosa dal momento in cui questo ha cominciato ad affermarsi come “il colore della femminilità”, in quanto veniva associato a un’immagine stereotipata e spesso offensiva della donna, rigorosamente filtrata attraverso una lente maschilista.
La Seconda Ondata Femminista degli anni ’60 e ’70 si è scagliata duramente contro il modello conservatore degli anni ’50, e nel farlo non ha certo risparmiato il colore rosa.
Le attiviste hanno cominciato a promuovere una visione “unisex” di abiti e giocattoli, che ha avuto un riscontro sull’offerta effettiva.
Jo B. Paoletti scrive che, dal 1976 al 1978, i cataloghi di Sears non riportavano neanche un capo di colore rosa per bambini o per bambine – esclusi un paio di capi per neonati.
Tuttavia, negli anni ’80 la codifica cromatica di genere tornerà più forte che mai insieme al ritorno a valori più tradizionali, sempre accompagnati dalla spinta consumistica: proporre giocattoli “per i maschi” e “per le femmine” convinceva le famiglie che avevano un figlio e una figlia a comprare minimo due prodotti alla volta.
Paoletti attribuisce il ritorno del concetto di “rosa per la femmina, azzurro per il maschio” alla nascita dei test prenatali: i genitori erano in grado di conoscere il genere del neonato prima della sua nascita, e volevano “ostentarlo” mediante l’acquisto di fiocchi, abitini e accessori rigorosamente gender-coded.
A metà degli anni ’80, quindi, la differenziazione cromatica diventa una strategia di marketing e il rosa torna prepotentemente ad essere sinonimo di femminilità.

Il processo ha continuato ad intensificarsi nei decenni successivi, raggiungendo il picco negli anni 2000.
Ad oggi, il rosa caratterizza ancora la maggior parte dei prodotti rivolti al target femminile, tanto che si parla di “pinkification”.
Fra i prodotti per bambine, il sovraccarico di rosa può essere ricondotto da un lato all’onnipresente Barbie, dall’altro al franchise delle Principesse Disney, in cui la principessa Aurora, con grande gioia di Flora, veste sempre in rosa.

Il Dopoguerra vede l’uscita dei primi giocattoli marcatamente “gender-specific”. Hasbro passa dal “gender-neutral” Mr. Potato Head alla produzione di action figure direttamente rivolte ai maschi, come G.I. Joe, nato nel 1964. Nel 1959, stesso anno d’uscita del classico Disney La bella addormentata nel bosco, nasce la Barbie di Mattel.
Rosa e femminismo
Rosa e femminismo di Seconda Ondata, un rapporto complicato
Come abbiamo accennato, le femministe degli anni ’60 e ’70 avevano maturato un rifiuto per il rosa in quanto simbolo della femminilità tradizionale, strettamente legata alla concezione patriarcale della donna.
Da un lato, il pensiero femminista tendeva ad annullare gli stereotipi di genere, dall’altro invitava le donne ad acquisire tratti stereotipicamente maschili al fine di essere prese sul serio: essere troppo “femminili” avrebbe limitato le loro possibilità nel lavoro e nella vita, sfavorendo la loro emancipazione.
Il concetto di “femminilità” viene quindi ripudiato dalle femministe, così come le donne che lo incarnano, considerate al meglio delle “vittime”, al peggio delle “complici” del sistema patriarcale
Tale giudizio appare, tuttavia, prigioniero della stessa visione maschilista: in una società davvero femminista, le donne iper-femminili dovrebbero essere prese sul serio, valorizzate e liberate tanto quanto le altre donne.
Come scrive Valerie Steele, curatrice della mostra PINK: The history of a punk, pretty, powerful color, “Il rosa provoca forti sentimenti di attrazione e di repulsione”.
Allo stesso modo, le donne che rispecchiano i canoni di femminilità stabiliti dal dominio patriarcale sono desiderabili dagli uomini, ma anche discriminate in quanto tali, sia dai maschilisti che dalle femministe di Seconda Ondata.
Possiamo parlare, invero, di un processo di demonizzazione della femminilità che trascende il genere sessuale: se una donna che assume tratti maschili sembra ottenere più rispetto, un uomo che assume tratti femminili viene automaticamente discriminato.
Come scrive Ritch C. Savin-Williams, professore in Psicologia alla Cornell University di Ithaca: “Alle ragazze viene concessa decisamente più libertà d’azione rispetto ai ragazzi per quanto concerne l’espressione di comportamenti e interessi che trascendono i generi, il che riflette in parte l’elevato prestigio di cui gode la mascolinità nella nostra cultura”.
Infatti, come spiegano Emily F. Coyle, Megan Fulcher e Darinka Trübutschek, autrici dello studio Sissies, Mama’s Boys, and Tomboys, la parola tomboy (“maschiaccio”), riferita ad una ragazza, non è mai stata considerata completamente negativa, al contrario di “sissy” (“femminuccia”) riferita a un ragazzo.
Chiudiamo citando un dialogo del film Il giardino di cemento (1993) di Andrew Birkin, ripreso da Madonna all’inizio della traccia What it Feels Like For A Girl (2000):
Girls can wear jeans and cut their hair short
Le ragazze possono indossare i jeans e tagliarsi i capelli corti
Wear shirts and boots ‘cause it’s okay to be a boy
But for a boy to look like a girl is degrading
‘Cause you think that being a girl is degrading
Indossare magliette e stivali perché essere un ragazzo è ok
Ma per un ragazzo assomigliare a una ragazza è degradante
Perché pensate che essere una ragazza è degradante
Insomma, all’ombra della Seconda Ondata, la femminilità stessa – slegata dal genere sessuale – sembrava condannata a rimanere sinonimo di inferiorità, per i maschilisti come per le femministe.
Rosa e femminismo di Terza Ondata: Lipstick Feminism
All’inizio degli anni ’90 prende vita la Terza Ondata del femminismo occidentale, che attraverso il Lipstick Feminism si riappropria della femminilità tradizionale privandola delle sue connotazioni sessiste.
Insomma: il problema non sono le donne a cui piace il rosa, ma la scarsa considerazione – assorbita dalla Seconda Ondata – che la società patriarcale ha nei loro confronti, basata su stereotipi di genere.
Alle porte del Nuovo Millennio, è giunto il momento di slegare il “femminile” da ogni connotazione negativa: femminilità non equivale a frivolezza, stupidità, inferiorità.
Il Lipstick Feminism promuove la femminilità tradizionale a risorsa di potere e autoaffermazione: La rivincita delle bionde ne diventa idealmente il manifesto.
La Rivincita delle Bionde (2001)
La rivincita delle bionde (Legally Blonde) è un film del 2001 scritto da Karen McCullah Lutz e Kirsten Smith, diretto da Robert Luketic.
“It had to be pink”
Chiunque abbia detto che l’arancione avrebbe sostituito il rosa è un disturbato mentale.
Elle Woods, Legally Blonde (2001)
Legally Blonde è tratto dall’omonimo romanzo di Amanda Brown, basato sulla sua reale esperienza di studentessa alla Facoltà di Legge di Stanford.
Amanda era bionda, appariscente e ultra-femminile, appassionata di moda e bellezza. Nel rigido ambiente universitario, la ragazza si sente come un pesce fuor d’acqua e si sfoga con i suoi genitori in lunghe lettere, poi decide di raccontare la sua esperienza in un libro. Inizialmente pensa a un libro autobiografico o a una raccolta di saggi, ma un agente letterario la convince a trasformare la sua idea in un romanzo.
L’autrice cerca di vendere il manoscritto a diverse case editrici, ma non ci riesce.
Poi ha un’idea geniale: decide di ristamparlo su fogli rosa e, questa volta, attira l’attenzione di un’agente e, presto, di Hollywood.
Il successo dell’escamotage, ripreso nel film – la protagonista stampa il suo CV su fogli rosa, attirando l’attenzione del suo professore – è un testamento dell’importanza del rosa in Legally Blonde.
Per questo motivo, sorprende il fatto che la costumista del film, Sophie De Rakoff, nutrisse dei dubbi in merito:
Ci recammo a visitare alcune sororities [in centro a Los Angeles]. Sapevamo che avevamo bisogno di trovare un colore distintivo [per Elle], e pensavamo, ‘Davvero vogliamo che sia il rosa? È così scontato. È così femminile. Non potremmo usare il lilla? Non potremmo usare l’azzurro? Non c’è un altro colore che potremmo usare?’. Quando però incontrammo le ragazze delle sororities, capimmo che doveva per forza essere il rosa.
“The backstory is, Reese and I, and maybe the production designers, went to visit some sororities [in downtown Los Angeles]. We knew that she needed a signature color, and we were like, ‘Do we really want it to be pink? It’s so on the nose. It’s so feminine. Could we do lavender? Could we do light blue? Is there another color that we could do?’ When we met all the sorority girls, it had to be pink.”
Jackie contro Marilyn
Se voglio diventare senatore prima dei 30 anni devo sposare una Jackie, non una Marilyn.
Warner Huntington III, Legally Blonde (2001)
Elle Woods è una studentessa di Fashion Merchandising (“marketing settore moda”), consorella della Delta Nu alla CULA (California University Los Angeles, versione fittizia della UCLA).

La sua vita sulla West Coast trascorre spensierata fino a quando un giorno il suo ragazzo, Warner, la invita a cena fuori.
Elle è elettrizzata perché pensa di ricevere una proposta di matrimonio. Invece Warner la lascia, spiegandole che – per diventare senatore entro i 30 anni, ha bisogno di “sposare una Jackie, non una Marilyn”.
Il cuore del film parte da qui, nel momento in cui la dicotomia “santa-puttana” si ripresenta nelle varianti di bruna contro bionda, intelligente contro stupida. Warren sostiene che una donna abbia solo due opzioni: può essere bionda, sensuale e stupida come Marilyn Monroe, o bruna, integerrima e intelligente come Jackie Kennedy.
Lo stereotipo legato alla rivalità fra “blondes” e “brunettes” può essere riassunto così, unendo i titoli dei due romanzi di Anita Loos del 1925 e 1927: Gli uomini preferiscono le bionde, ma sposano le brune.
L’attrazione provata verso le bionde è più “fisica”, mentre quella verso le brune, solitamente raffigurate come donne dall’aspetto più naturale e rassicurante, è più razionale.
Tale schema limita le potenzialità delle donne e le mette l’una contro l’altra, prigioniere di una dicotomia che il film non esiterà a demolire.
Marilyn e Jackie vestono sia nelle tonalità del rosa pallido che in quelle del rosa shocking.
Bionde stupide
Divento intelligente quando serve, ma alla maggior parte degli uomini non piace.
Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde (1953)
L’attrazione degli uomini verso le donne con capelli biondi ha radici antichissime e sembra sia legata al gene recessivo che rende tale caratteristica più rara e, quindi, più ricercata.
I capelli biondi sono una caratteristica facilmente riscontrabile fra i bambini e le bambine di razza caucasica, ma in buona parte dei casi si scuriscono in età adulta: come il colore rosa, anche il capello biondo è associabile all’infanzia e, quindi, a un’ingenuità che può sfociare nella stupidità. Forse non è un caso che, nel linguaggio popolare americano, sia stato adottato il termine italiano “bimbo” (cioè “bambino”) per riferirsi a donne attraenti e stupide, spesso bionde – questo si ricollega allo stereotipo secondo cui una persona di bell’aspetto non può anche essere intelligente.
All’attrazione fatale che si prova per le donne con questo colore di capelli si aggiunge quindi una componente di ingenuità infantile che permette all’uomo di sentirsi in una posizione di superiorità: davanti ad una bionda stupida, il maschio può esercitare un controllo che non gli è concesso in relazione ad altre figure femminili, anche bionde (vedi “icy blonde” e “bombshell blonde”).
Spesso, tuttavia, sono proprio le “bionde stupide” a sfruttare lo stereotipo a loro favore, a testimonianza della natura potenzialmente sovversiva del “trope” in questione.
Ad esempio, Lorelei (Marilyn Monroe) de Gli uomini preferiscono le bionde non è in grado di capire come si indossa una tiara, ma quando si tratta di raggiungere il suo obiettivo (i diamanti!), “diventa intelligente” e rivolta gli uomini a suo piacimento senza che questi sospettino nulla.
Paris Hilton, la “dumb blonde” più famosa del nostro tempo, ha giocato per anni a interpretare un personaggio che le ha portato fama e fortuna, grazie al quale ora gestisce un impero milionario (“Non sarei arrivata così lontano se fossi stata una bionda stupida”).
Ad oggi, come appare evidente nel suo recente documentario, Paris sembra allo stesso tempo grata e pentita per il fatto di aver ottenuto successo fingendosi stupida, a testimonianza della natura potenzialmente deleteria dello stereotipo in questione.

Sullo sfondo, la Casa Bianca dipinta di rosa, come canta nel singolo Paris For President (2008).
Questo sembra quasi un riferimento alla già citata Mamie Eisenhower: pare infatti che la First Lady avesse arredato la Casa Bianca in rosa, al punto che alcuni reporter l’avevano ribattezzata “The Pink Palace”.
L’intento di Elle Woods non è però quello di nascondere l’ingegno dietro a una cascata di capelli biondi, ma di dimostrare come le due cose possano convivere alla luce del sole.
Elle, quindi, a differenza di Lorelei e di Paris, non sfrutta il “trope” della bionda stupida, ma lo distrugge.
Watch Me Shine
Vi dimostrerò quanto vale Elle Woods!
Elle Woods, Legally Blonde (2001)
Fin dalle prime scene, Legally Blonde non esita a mostrarci che, dietro ai capelli biondi e a tutto quel rosa, Elle Woods è una donna intelligente: grazie alla sua conoscenza in fatto di sartoria e di alta moda, se la cava brillantemente quando una commessa (bruna) cerca di “fregarla” facendole pagare un capo più del dovuto.
D’altronde, sappiamo che Elle ha la media più alta del suo istituto.
Questo, però non basta: la sua competenza in fatto di moda, bellezza e cura di sé, ambiti stereotipicamente considerati “femminili”, contribuisce a farla apparire “inferiore” agli occhi della società.
Quando Elle, nel disperato tentativo di riconquistare il suo ex ragazzo, decide di iscriversi alla Facoltà di Legge di Harvard, capiamo che la società non la ritiene all’altezza: questo viene ribadito da Warren, ma anche dalla consulente per l’orientamento (che pur indossa un maglione rosa).
Al contrario, le amiche e le consorelle di Elle non mettono mai in dubbio le sue capacità: dopo un accenno di perplessità (“Ma non è difficile?”), la supportano nel suo obiettivo.
Oltre a superare brillantemente il test d’ammissione, Elle realizza un peculiare video-essay che finisce per trovare il consenso della commissione.

Analizzando il video in questione, alcuni studiosi ritengono che Elle stia cercando di attirare l’attenzione mettendo in mostra il suo corpo, e che questa sia una prima testimonianza della natura potenzialmente sovversiva del “trope” della bionda stupida, ma il film sembra suggerire che quella di Elle sia una mossa assolutamente spontanea e genuina, puntando l’attenzione sugli aspetti surreali del personaggio, più che sulla sua fisicità.
Si può dire che i membri della commissione, tutti uomini, siano impressionati (anche) dalla sua bella presenza, ma l’ammissione di Elle si pone comunque sulla base dei suoi buoni voti.
Questo passaggio viene raffigurato, metaforicamente, da una scelta di inquadrature: mentre i membri discutono in merito alla sua ammissione, vediamo inquadrato lo schermo in cui il video è stato proiettato, che mostra solo il fisico di Elle.

Quando la decisione di ammetterla è stata presa, la videocamera zooma sul volto della ragazza, lasciando da parte il corpo in bikini.
Alla fine, Elle è stata ammessa per il suo cervello e per la sua individualità (“Aren’t we always looking for diversity?”, chiede uno dei membri).
La scoppiettante personalità di Elle passa dal video alla realtà nella scena del suo arrivo ad Harvard: la ragazza fa il suo ingresso in un “total look” rosa, guadagnandosi l’epiteto di “Malibu Barbie” (in italiano, “una Barbie in carne ed ossa”).

Il riferimento alla California è fondamentale perché è un altro motivo di discriminazione per la nuova studentessa: Elle proviene da Los Angeles, quindi dalla West Coast, mentre Harvard si trova sulla costa opposta. “East Coast people are different”, le ricorda Warner appena dopo averla lasciata, e il contrasto fra Elle e i suoi compagni di corso si vede anche in questo.
Per gli studenti di Harvard, la California è sinonimo di frivolezza, un mondo in cui le bionde stupide sembrano trovare la loro naturale collocazione.
Al contrario, Malibu Barbie non è la benvenuta ad Harvard.
Per la sua prima lezione, Elle cambia completamente, passando da uno stereotipo all’altro: da Malibu Barbie alla sua personalissima concezione di come una studentessa di Harvard dovrebbe essere.
Per lei non è altro che un travestimento, tanto che afferma soddisfatta “I totally look the part”.
Il risultato è un ibrido bizzarro e innaturale: si vede che, a questo punto della trama, le motivazioni di Elle non sono genuine.
Infatti, il suo unico scopo è quello di riconquistare Warren.
Elle, quindi, si camuffa, permettendosi come unica concessione un’estrosa penna di pelo rosa (curiosamente simile a quella di Cher di Clueless) e un block notes a forma di cuoricino.
La figura di Elle sembra sovrapporsi allo stereotipo della “Valley Girl” californiana, stile Cher di Clueless (1995): una ragazza ricca e alla moda, viziata e superficiale (almeno all’apparenza).
Il suo travestimento, guidato da intenti superficiali, viene subito smascherato dalla professoressa Stromwell, che non esita a metterla contro un’altra studentessa, la bruna Vivian Kensington.
La dicotomia Jackie-Marilyn torna quindi prepotentemente al centro della scena come base di una competizione promossa non solo dall’uomo (Warren), ma anche dalle altre donne: la professoressa, avendo appurato che Elle non è preparata sui testi in programma, chiede alla bruna se crede che la bionda debba abbandonare l’aula.
Vivian, con grande sgomento di Elle – abituata alla solidarietà femminile della sorority – risponde affermativamente.
Come se non bastasse, nella scena successiva si scopre che Vivian è la nuova fidanzata di Warren.
L’umiliazione porta Elle, in lacrime, a vagare per la città fino a quando non trova un locale a metà fra un hair salon e un centro estetico (Neptune’s Beauty Nook Hair & Nails).
È da evidenziare il fatto che la ragazza trovi rifugio in quello che – almeno per gli standard del quartiere – può essere considerato un tempio della cura del corpo, della bellezza, etc.
Per buona parte del film, questo diventa il “safe space” di Elle a Harvard: è l’unico ambiente in cui può fare amicizia ed essere sé stessa, l’unico posto in cui vige il concetto di “sorellanza” a lei tanto caro, qui arricchito da una spinta all’inclusività che – in linea con i valori della Terza Ondata – la vede interagire con donne di diverse etnie e fisicità.
Nei giorni successivi, Elle torna al campus.
Prima si mostra agguerrita: di fronte a Vivian afferma “Non ho paura di una sfida”, poi mostra il suo fisico – con un secondo fine, in questo caso – di fronte a Warren e ai suoi amici.
Dopo cerca un contatto con le buone maniere, offrendo dei muffin per partecipare alla sessione di studio di Warren e Vivian.
Infine, accetta di buon grado l’invito di quest’ultima per una “festa in maschera”, che si rivela essere una trappola: in realtà, nessuno degli altri invitati è mascherato.
Ignara di questo, Elle si traveste da coniglietta di Playboy.
Questa sequenza, più di tutte, mette in scena la dissonanza fra la percezione che Elle ha di sé stessa e quella che gli altri hanno di lei.
Per Elle, quello della “playmate” è solo un travestimento.
Per gli altri, è la perfetta rappresentazione della percezione che hanno di lei.

Questa si può dire che sia l’unica scena in cui Elle sfrutta lo stereotipo della bionda svampita per fare buon viso a cattivo gioco, affermando con disinvoltura “Mi andava così” alla domanda di Warren sul motivo per cui si è conciata in quel modo.
In realtà noi vediamo che Elle, appena messo piede alla festa, ha capito l’inganno di Vivian e le ha risposto a tono.
Tuttavia, la conversazione con Warren la trasforma in poche battute da consapevole manipolatrice a vittima sacrificale del suo stesso stereotipo: nonostante lei sia riuscita a entrare a Harvard, Warren continua a vederla solo come una “playmate”, come tutti gli altri.
Il ragazzo la scoraggia dicendo che ogni suo sforzo per eccellere alla facoltà di Legge sarebbe vano (“You can do something more valuable with your time”).

Elle abbandona quindi la festa, dichiarando: “I’ll show you how valuable Elle Woods can be!”.
In inglese, il pronome “you” suona ambiguo: Elle si sta riferendo a Warren o a un più generale “voi”, includendo studenti, professori, spettatori del film e, in ultimo, anche sé stessa?
La traduzione italiana volge la frase al plurale, ma l’originale conserva un’ambivalenza che fa riflettere. Elle si è iscritta ad Harvard per riconquistare Warren, quindi da un lato è lecito pensare che in questo punto del film lo dica pensando a lui, dall’altro è evidente che la storia la porti a combattere per un bene più grande: non più l’attenzione di un uomo, ma la sua realizzazione personale.
È questa la strada che, alla fine, la condurrà al trionfo.
Anche Il Diario di Bridget Jones, uscito nello stesso anno di La rivincita delle bionde, presenta una scena in cui la protagonista viene messa in ridicolo per mezzo di un abito da coniglietta, indossato ad una festa di cui fraintende la natura. Quest’umiliazione, secondo Carol M. Dole, è un avvertimento per le donne che, all’alba del Nuovo Millennio, decidano di mettere in luce la propria sensualità in pubblico, in una società ancora fortemente maschilista. Nel caso di Elle, il messaggio è “Non sarai mai niente di più”, nel caso di Bridget vengono evidenziate le caratteristiche fisiche che non le permettono di aderire al modello di sensualità promosso dalla società patriarcale.
La Rivincita del Rosa
Il rosa non è solo un colore, è un atteggiamento.
Miley Cyrus
Nella scena appena successiva, Elle si disfa della sua penna di pelo rosa e acquista un computer portatile di colore arancione, poi la vediamo allenarsi e studiare con addosso un top dello stesso colore.
Curioso, considerato che nelle sue prime scene ad Harvard aveva definito “un disturbato mentale” chiunque sosteneva che l’arancione avrebbe sostituito il rosa.
E invece, più Elle prende seriamente Harvard, più vediamo il rosa scomparire.
Più tardi, tuttavia, questo farà un’apparizione degna di nota nel curriculum vitae (rosa e profumato) che le garantirà la partecipazione al tirocinio formativo a cui aspirava – un riferimento alla fortuna che il manoscritto rosa aveva riservato all’autrice del romanzo.
Durante il tirocinio, il suo abbigliamento diventa “classy” e “minimal”, da ufficio: il rosa, quando compare, si ritrova in secondo piano, soffocato da giacche e maglioni scuri.

Il caso a cui Elle deve lavorare con il professor Callahan e alcuni compagni del primo anno – fra cui Warren e Vivian – ha a che fare con l’istruttrice di fitness Brooke Windham, che si rivela essere un membro delle Delta Nu, come Elle. La storia della donna, accusata dell’omicidio del marito, permette alla protagonista di rientrare in contatto con il suo vecchio mondo, fatto di bellezza e cura del corpo – non a caso, intravediamo un accenno della “vecchia” Elle quando si mostra perplessa di fronte al colore della divisa che Brooke è costretta ad indossare in carcere, l’arancione.

Inoltre, questa è la prima volta in cui Elle dimostra l’importanza della solidarietà femminile di fronte a compagni e professori di Harvard: fino a quel momento, il concetto di “sorellanza” era relegato all’ambiente “Hair&Nails” in cui lavora l’amica Paulette, anche se Elle aveva sfruttato le sue conoscenze accademiche per aiutarla contro l’ex marito.
Quando Elle si rifiuta di dichiarare l’alibi dell’imputata per non venire meno alla parola data alla consorella, Vivian rimane positivamente colpita e questo porta a un’avvicinamento fra le due, che si rendono conto di essere state messe una contro l’altra dalle circostanze – e dagli uomini della loro vita.
Nella scena successiva, il professor Callahan invita Elle nel suo studio: si congratula per la sua arguzia e, sfiorandole una gamba, le fa capire che può garantirle una carriera di successo in cambio di favori sessuali.
Elle, offesa e ferita, scappa via.
Un altro stereotipo che viene sfatato nel film è quello secondo cui una giovane ragazza bella e stupida possa avere successo accademico e professionale solo ricorrendo a compromessi che sarebbe ben propensa ad accettare.
Qui Vivian cade completamente vittima dei suoi stessi preconcetti, pensando che Elle abbia accettato le avances del professore.
La scena che segue è un’accurata rappresentazione della possibile reazione di una donna dopo un’avance di questo genere, percepibile come un’effettiva molestia: Elle si sente sbagliata, si sminuisce, non vuole saperne più niente del tirocinio, né della laurea in Legge.
È curioso notare come l’interesse sessuale del professore nei confronti di Elle si sia manifestato solo a seguito della dimostrazione del suo intelletto, il che sembra in contrasto con la conclusione a cui arriva quest’ultima (“In me vede solo una modella di Victoria’s Secret, come tutti gli altri”).
Tuttavia, questa non può che essere la massima dimostrazione di come qualunque tipo di molestia non possa mai essere percepita come un “complimento”, a prescindere: la reazione della vittima è tendenzialmente auto-distruttiva, come in questo caso.
Nella conversazione con Emmett Richmond, partner legale del professor Callahan con cui Elle ha gradualmente costruito un rapporto di amicizia, escono fuori alcuni concetti chiave che porteranno alla “rivincita” finale.
Elle ammette che la scomparsa del rosa non era casuale, ma era voluta, nel tentativo di essere “qualcun altro”.
Basta abiti noiosi, basta tentativi di essere quella che non… che non sono.
Emmett, nell’adattamento italiano, risponde:
Che ne dici di provare ad essere te stessa?
In originale, però, la battuta è più profonda e incisiva:
E se stessi cercando di essere quella che sei?
What if you’re trying to be somebody you are?

Lo stesso Emmett, qualche scena prima, aveva suggerito che i biondi capelli di Elle potessero costituire una forma di “empowerment”:
Sai, in realtà essere una bionda è una cosa piuttosto potente.
“You know, being a blonde is actually a pretty powerful thing. You hold more cards than you think you do.”
Hai più assi nella manica di quello che credi.

Con il suo atteggiamento, Emmet si rivela essere, in contrasto con Warren, un modello maschile positivo, in grado di supportare Elle, incitandola a riappropriarsi di quelle caratteristiche che la rendono unica e, quindi, potente.
La realizzazione finale avviene poco più tardi, nel salone di Paulette. Elle vi si reca per salutare l’amica, raccontandole la sua volontà di ritirarsi. Lei non sa, tuttavia, che ad ascoltarla, seduta su una delle poltrone del salone, c’è la professoressa Stromwell, la stessa che l’aveva cacciata fuori dall’aula alla prima lezione.
Quest’ultima, alzandosi in piedi, dichiara:
Se permetterai a uno stupido coglione di rovinarti la vita, non sei la ragazza che credevo!
“If you’re going to let one stupid prick ruin your life… you’re not the girl I thought you were”.

È una manifestazione di solidarietà femminile che si pone in diretto contrasto con il primo incontro fra le due donne.
Il valore simbolico della scena è fortissimo e trascende la narrazione, diventando una metafora della riconciliazione fra due generazioni di femministe.
Lo scontro è fra la Seconda Ondata femminista e la Terza, attaccata dalle veterane per la sua natura apparentemente più superficiale e frivola, che all’impegno politico di marce e petizioni preferisce il disimpegno della cultura pop. Sotto la patina di leggerezza e glamour, però, i valori sono gli stessi delle “sorelle maggiori” degli anni ’60 e ’70: come scrive Glynis O’Leary, Legally Blonde presenta “concetti base dell’attivismo, temi femministi di indipendenza, pari opportunità, sorellanza, e la sovversione delle istituzioni patriarcali”.
La professoressa Stromwell, con il suo abbigliamento austero – quasi maschile – che le ha permesso di farsi strada in un mondo di uomini, incarna la Seconda Ondata femminista che finalmente riconosce il valore della Terza, incarnata da Elle, e la supporta nella battaglia comune contro gli abusi del patriarcato, impersonificato dal professor Callahan.

In linea con i valori della Terza Ondata, di cui Elle diventa il vessillo, la sezione finale del film celebra la riappropriazione della femminilità, metaforicamente incarnata dal colore rosa.
Elle torna in campo come avvocata della consorella Brooke, sostituendo Callahan, e lo fa entrando in aula con un trionfale look “total pink” che le permette di spiccare in mezzo a tutti gli astanti.

La spumeggiante personalità di Elle passa anche attraverso questa caratteristica, simbolo di un interesse per la cura dei capelli che le tornerà utile nel corso del processo.
I capelli biondi di Elle e della sua assistita Brooke si contrappongono alle tinte più scure delle donne che stanno dall’altro lato della barricata: l’avvocata, la testimone e sua madre.
Questo è il momento in cui Elle prende definitivamente coscienza del fatto che può essere entrambe le cose: una donna che impazzisce per il rosa e una seria professionista.
L’outfit di Elle, che la costumista del film definisce “her true self”, è il risultato di tutto quello che ha imparato fino a quel momento: è appariscente, ma ha comunque un taglio professionale.
Non è pacchiano come la tenuta in pelle che indossava all’arrivo ad Harvard, ma è comunque un testamento della sua estrosa e scintillante personalità.
Alla fine, Elle è riuscita a far conciliare diversi lati di sé, apparenti contraddizioni che – come vuole la Terza Ondata – possono benissimo convivere fra loro.
Il trionfo passa proprio attraverso quelle competenze stereotipicamente “femminili” che, nel corso del film, vengono continuamente sminuite.
Elle riesce a far confessare la colpevole perché sa che i capelli, dopo una permanente, non vanno bagnati per almeno 24 ore. Questa è una conoscenza che condivide con le sue amiche – anche le meno istruite – ma buona parte degli avvocati presenti probabilmente non lo sa. Viene quindi evidenziata l’importanza di un bagaglio di competenze troppo spesso sottovalutato, che si rivela qui fondamentale.
Elle si esprime con una terminologia tecnica molto accurata, a testimonianza del valore scientifico delle sue parole, salvo poi ribadire: “Any Cosmo girl would have known”, “Ogni ragazza che legge Cosmopolitan l’avrebbe saputo”.

«Il mercoledì ci vestiamo di rosa»
Vincendo la causa, Elle si riappropria del rosa, che trionfa in tutta la sua gloria.
È interessante paragonare questa risoluzione al finale di uno dei più importanti teen movie di tutti i tempi, Mean Girls (2004).
Spesso, nei film e nelle serie tv per adolescenti, il rosa è indossato dalle “ragazze cattive” che ostacolano la protagonista, e Mean Girls non fa eccezione: le tre Plastics (“Barbie”, nell’adattamento italiano) hanno addirittura una regola secondo cui “il mercoledì ci vestiamo di rosa”.
Il rosa costituisce una metafora della femminilità estrema, rappresentata dal trucco, dall’attenzione all’aspetto estetico e dalla cura di sé: tutti aspetti che vengono connotati negativamente.
Notiamo infatti come la redenzione finale porti la perfida Regina George a utilizzare un abbigliamento più modesto, con un look “acqua e sapone”, da “brava ragazza”.
Intendiamoci: c’è sicuramente un’esigenza narrativa dietro la volontà di rendere manifesto il cambiamento di Regina anche a livello estetico, ma c’è da chiedersi che messaggio recepiscano le ragazze che apprezzano il trucco, le minigonne, il rosa (che, per fortuna, fa ancora capolino sulla sua t-shirt!).
La domanda è: se manifesti la tua femminilità in modo estremo, sei automaticamente una “cattiva ragazza”?
Anche Mary Fisher di She-Devil (1989) va incontro a un destino simile: alla fine del film, abbandona la “frivolezza” degli abiti e dei romanzi rosa per diventare una scrittrice impegnata, con un look più “da intellettuale” (anche se gli occhialoni mantengono un tono di rosa).
Decisamente più positiva la visione di Clueless (Ragazze a Beverly Hills, 1995): anche in questo caso, la protagonista (Cher Horowitz) compie un percorso di crescita, ma l’esito è diverso.
Il personaggio di Cher ricorda quello di Elle: anche lei viene sottovalutata, diventando vittima dello stereotipo della “Valley Girl”, la figlia di papà viziata, egocentrica, superficiale e un po’ stupida.
Rosalind Sibielski scrive che Clueless, come Legally Blonde, promuove il trionfo di conoscenze considerate “frivole” (stereotipicamente femminili) in contesti “seri” (storicamente caratterizzati dal dominio maschile), portando come esempio la scena della discussione sull’immigrazione, nella quale Cher fa la metafora di una festa di compleanno per spiegare la situazione degli haitiani, mettendo a frutto l’abilità di essere una buona padrona di casa nel contesto di un “debate” inerente questioni politico-sociali.
In realtà, visionando la scena in questione, non si può parlare di un vero e proprio trionfo. Tuttavia, non si può negare che il suo discorso appaia comunque sensato alle orecchie dello spettatore: il concetto è giusto, anche se la forma con cui è stato espresso lascia un po’ a desiderare…
Nel corso della sua storia, Cher dimostra di essere una ragazza intelligente, profonda e altruista, ma questo non la obbliga a cambiare stile di vita e interessi, anzi: l’iper-femminilità la aiuta nel suo percorso, anziché ostacolarla. Gran parte delle “buone azioni” che compie sono legate a caratteristiche, conoscenze e abilità stereotipicamente femminili, ad esempio quando decide di aiutare Tai, la nuova arrivata, con il suo look.
Nell’ultima parte del film, l’abbigliamento di Cher appare meno appariscente, ma nella scena finale riesplode nuovamente in tutta la sua rosea gloria.
Cher è cresciuta, ma la sua passione per la moda e la cura di sé è rimasta intatta, dimostrando alle ragazzine come queste caratteristiche non siano intrinsecamente negative.

Questo è ancora più rivoluzionario se pensiamo che Cher ha diverse caratteristiche stereotipicamente legate alle “cattive” di film e serie tv rivolti a un pubblico di bambine e adolescenti: è bionda, ricca, viziata, amante del rosa.
Sharpay Evans dalla trilogia di High School Musical (2006-2008) e Meredith Baxter-Dimly di Bratz (2007).
Oltre alla demonizzazione di interessi e caratteristiche stereotipicamente femminili, il fatto che molte “cattive” siano bionde sembra ricollegarsi al discorso sulla rarità di questo colore di capelli, piuttosto ricercato rispetto al più comune castano: questo le rende attraenti e, di conseguenza, altezzose, andando a creare un altro stereotipo, quello della bionda cattiva e snob.
Naturalmente, la componente che più di tutte giustifica il loro atteggiamento è il fatto che appartengano, mediamente, ad uno status sociale più alto rispetto a quello della protagonista.
Anche se esistono “cattive” brune, soprattutto se le protagoniste sono bionde, per qualche ragione sono le cattive bionde ad apprezzare maggiormente il rosa, il che sembrerebbe reiterare lo stereotipo sulla loro natura frivola.
Megan Fox in due ruoli da “mean girl”, prima in Holiday in the Sun (2001), in contrasto con le biondissime Ashley e Mary-Kate Olsen, poi in Confessions Of A Teenage Drama Queen (Quanto è difficile essere teenager!, 2004), affianco ad una Lindsay Lohan con i capelli tinti di biondo.
Esiste, tuttavia, qualche eccezione: Rizzo di Grease (1978), a capo della gang delle Pink Ladies, e la professoressa Umbridge di Harry Potter (2001-2011), hanno i capelli mediamente scuri, ma vestono di rosa.

In Grease, il carattere di Rizzo contrasta con quello di Sandy, che incarna lo stereotipo della bionda-bambina, innocente e angelica.
Anche qui, la bruna viene dipinta come più avveduta della bionda, che non sa “come gira il mondo”.

Clicca qui per leggere il mio post su Sharpay.

You can have it all.
Legally Blonde potrebbe anche finire con la vittoria in tribunale, una lectio magistralis in Lipstick Feminism.
Tuttavia, vedere Warren correre dietro ad Elle per chiederle di tornare insieme, per poi essere respinto con la stessa medicina (“Per diventare socia di uno studio legale entro i 30 anni avrò bisogno di un fidanzato che non sia un perfetto idiota”), costituisce una necessaria risoluzione del percorso personale della protagonista.
Detto questo, bisogna segnalare l’altalenante intento delle sceneggiatrici, indecise se dare più enfasi alla realizzazione personale di Elle o alla storia d’amore che, nel frattempo, era sbocciata con Emmett. La sequenza del tribunale finiva, inizialmente, con un bacio fra i due, ma la scena, secondo MccUllah Lutz, “non convinceva, perché [Legally Blonde] non è una commedia romantica – non si basa sulla loro relazione”. Il finale proseguiva con un salto temporale di un anno, con Elle e Vivian (ora bionda) impegnate a gestire un “Blonde Legal Defense Club”, ma la sceneggiatrice spiega che “durante i test screening, il pubblico voleva sapere cosa succedeva ad Elle, voleva vederla avere successo”.
Il finale in programma è stato quindi cestinato e sostituito con una scena che mostra la sua cerimonia di Laurea.


Il film termina quindi con il successo accademico della protagonista, anche se una scritta in sovrimpressione ci informa che “Emmett chiederà ad Elle di sposarlo. Stasera”.
Tale precisazione, per quanto superflua, opera come una nota a piè di pagina a testimonianza del grande mantra del femminismo di Terza Ondata: la consapevolezza che “Women can have it all“.
Le donne possono avere tutto: un guardaroba “total pink”, una scintillante carriera, un bella storia d’amore e… perché no?
Un bel matrimonio, che per Elle avrà luogo nel sequel Legally Blonde 2: Red, White & Blonde (Una bionda in carriera), del 2003.
Il matrimonio di Elle va in contrasto con l’immagine stereotipata che i media dipingono delle avvocate, raffigurate come donne che hanno rinunciato all’amore per la carriera.
Anche Sex And The City (1998-2004) gioca sul “trope” in questione con il personaggio di Miranda che, pur ricalcando lo stereotipo dell’avvocata stressata, cinica e disillusa, sarà la prima delle sue amiche ad avere un bambino e, in seguito, si sposerà, dimostrando come sia possibile conciliare lavoro, amore e famiglia senza rinunciare alla propria personalità.
You can be anything.
Completiamo il discorso citando un’altra icona bionda amante del rosa.

Parliamo ovviamente di Barbie, la fashion doll più longeva al mondo.
Il suo amore smisurato per tutto ciò che è ultra-femminile non l’ha certo fermata: in 60 anni ha fatto qualunque mestiere, dall’astronauta alla presidente degli Stati Uniti, insegnando alle bambine che potevano diventare qualunque cosa volessero. Potevano avere la carriera dei loro sogni, una macchina, una casa tutta loro… ma anche un matrimonio e un guardaroba da favola, tutto in rosa.
Barbie per prima ci ha insegnato che una donna può essere tante cose diverse allo stesso tempo, tanti quanti i mestieri e i ruoli che ha ricoperto, e quindi non dovremmo meravigliarci del fatto che “Barbie Malibu” possa diventare “Barbie Avvocato”.
E poi, nel sequel – in barba alla dicotomia reiterata da Warner – Elle dimostra di poter essere anche anche “Barbie Jackie Kennedy” quando fa la sua trionfale entrata alla Casa Bianca.
In fondo, se si pensa che la stessa First Lady aveva una grande passione per il rosa, forse le “Jackie” e le “Marilyn” non sono poi così diverse…

Rivoluzione in rosa
A partire dagli anni ’60, la controcultura ha cominciato a riappropriarsi del rosa, che da simbolo del dominio patriarcale diventa vessillo rivoluzionario, dalla pop art al punk.
È soprattutto nella sua veste “shocking” che il rosa diventa il colore della ribellione: in fondo, è una tinta sgargiante, sfacciata, che si fa notare. Come se urlasse.
La rivoluzione più grande, quando si parla di rosa, non può prescindere da una questione di genere, a cui il colore rimane ancora oggi strettamente legato.
Come scrive Holly Lawley:
Il rosa non può essere apprezzato senza abbracciare e, allo stesso tempo, rifiutare, la connotazione [di genere] ad esso storicamente correlata.
Pink cannot be appreciated without both embracing and rejecting the historical connotations it holds.
Se è un uomo a indossarlo, assumiamo che voglia ribellarsi al concetto di mascolinità senza pensare che, semplicemente, possa apprezzare il colore per quello che è.
E se è una donna a vestire di rosa?
Il discorso, incurante del gusto personale, è ancora più complesso: Alice Bucknell definisce il rosa una “spettacolare contraddizione”, che allo stesso tempo imprigiona la donna e la libera.
Vestirsi di rosa diventa un gesto rivoluzionario quando a farlo sono donne che si riappropriano della femminilità privandola della sua connotazione patriarcale.
Uno dei primi esempi risale agli anni ’80: le donne cominciano a farsi strada ai piani alti delle più grandi aziende americane indossando completi rosa per rivendicare la loro femminilità in un ambiente fino a quel momento dominato dagli uomini.
Il messaggio, come riassume Valerie Steele, era chiaro: “Credi che il rosa non sia un colore serio perché è associato alle ragazze e alle donne, ma noi lo renderemo serio”.
Il rosa assume quindi una connotazione femminista che non neutralizza la femminilità, ma distrugge i preconcetti ad essa legati: una donna può raggiungere il successo professionale senza dover assumere tratti stereotipicamente maschili.

Mattel recepisce il messaggio e, nel 1985, lancia sul mercato la Day-to-Night Barbie, una donna in carriera che veste in “total pink”.
L’aspetto vivace e appariscente del rosa, quasi una caricatura della femminilità, funge da megafono per le voci delle donne nella società contemporanea.
Possiamo citare diversi esempi di riappropriazione del rosa in ambito politico-sociale, dalla divisa della Gulabi Gang in India ai “Pussy Hat” indossati dalle donne americane per manifestare contro Donald Trump. Oppure ancora le attiviste dell’associazione CodePink, che vestono in rosa per riappropriarsi del potere sui propri diritti sociali, sessuali e riproduttivi.
Il rosa diventa quindi il simbolo della ribellione al sistema patriarcale, della lotta per esprimere e affermare la propria femminilità come meglio si crede.
Quando queste battaglie saranno vinte, potremo davvero parlare di rivincita del rosa.
Quest’articolo è dedicato a mia mamma, che si è sposata con un abito rosa shocking, da donna in carriera… a dimostrazione del fatto che, nella vita, avrebbe sempre fatto a modo suo.
Il logo di heroica presenta un elemento rosa shocking in suo onore, simbolo di un cuore folle e rivoluzionario.

Bibliografia
Broadway, Anna. Pink Wasn’t Always Girly, 2013.
https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/08/pink-wasnt-always-girly/278535/
Bucknell, Alice. A Brief History of the Color Pink, 2017.
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-history-pink
D’Avignon, Angella. Pretty in Pink: How a Color Came to Represent a Gender, 2016.
https://www.vice.com/en/article/ezjeep/pretty-in-pink-how-a-color-came-to-represent-a-gender
Davis, Lisa Senis. Like Tomboys and Hate Girlie Girls? That’s Sexist, 2018.
https://www.nytimes.com/2018/12/19/opinion/tomboys-girlie-girls-sexism.html
Dole, Carol M. “The Return of Pink: Legally Blonde, Third-Wave Feminism, and Having It All,” in Chick Flicks: Contemporary Women at the Movies, editato da Ferriss, Suzanne e Young, Mallory, pp 58-78, 2008.
Ivey, Madison. Questions of the Pink Dress: Gender Representation and Perception in Turn-of-theCentury Chick Flicks, 2017.
Lawley, Holly. Think Pink, Think Feminism, 2018.
https://thestray.org/2018/11/20/think-pink-think-feminism/
McKeon, Lauren. Think pink — but not because marketing execs think you should, 2017.
https://www.tvo.org/article/think-pink-but-not-because-marketing-execs-think-you-should
Moreno, Jazmine M. From Blonde to Brutal: A Feminist Rhetorical Analysis of Legally Blonde and How to Get Away With Murder, 2017.
Sibielski, Rosalind. What Are Little (Empowered) Girls Made Of?: The Discourse of Girl Power in Contemporary U.S. Popular Culture, 2010.
Stamberg, Susan. Girls Are Taught To ‘Think Pink,’ But That Wasn’t Always So, 2014.
https://www.npr.org/2014/04/01/297159948/girls-are-taught-to-think-pink-but-that-wasnt-always-so
Vanette, Dora. The Complicated Gender History of Pink and Blue, 2019.
https://awomensthing.org/blog/childs-play-pink-blue-gender-history/
Wolchover, Natalie. Why Is Pink for Girls and Blue for Boys?, 2012.
https://www.livescience.com/22037-pink-girls-blue-boys.html

Dedicato a S., perché possa trovare qualcosa di sé mentre è intenta a cercare qualcos’altro.
Articolo di: Leone Locatelli